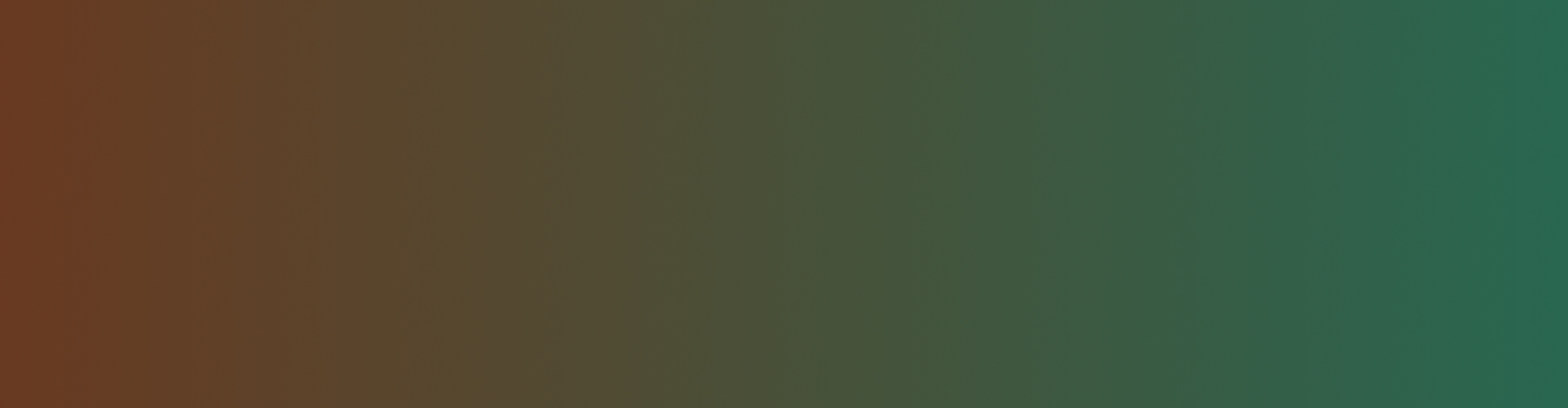Questo articolo è precedentemente stato pubblicato nel blog di Fanpage il 13 luglio 2017, prima che suddetto blog venisse chiuso. Alcune parti sono state modificate per attinenza con l’attualità
Ha ragione Levante: c’è un menefreghismo collettivo, dovuto alla sensazione di iper-individualizzazione virtuale che, nella realtà dei fatti, rasenta falsi moralismi. E ce ne accorgiamo. Ma non ce ne frega niente lo stesso.
Cosa succede al mondo intorno a noi? Ogni giorno, la sensazione che sentiamo, appena ci alziamo e apriamo lo smartphone – prima ancora di mangiare o lavare le nostre parti intime -, è definita “menefreghismo collettivo”. Già, viviamo in minuscoli cunicoli mentali, lobotomizzati dall’esigenza di essere protagonisti per un nanosecondo, pubblicando sogni di pace nel mondo per un pubblico che, al massimo, ti fa un pollice virtuale in su, e neanche usa la mano per salutarti per strada. Comodo, molto comodo (soprattutto per la coscienza).
Parlare di massa è fuorviante, perché almeno la massa ha un’ideologia, un credo comune. Invece, l’individuo moderno è asociale, cinico, arrogante e sfiduciato. Non solo dalla propria società, persino nei confronti dei propri simili, i quali diventano fastidiosi nemici della propria realtà. Sia gli accondiscendenti, sia i reazionari. In tutto ciò, «noi siamo tutti uguali, ma il colore della pelle conta». E si crea uno slogan, si guarda al dettaglio populista, e intanto gridiamo “aiutiamoli a casa loro”. Case, le loro rase al suolo dalle bombe, mentre le nostre ancora in piedi.
Manca la capacità di fare rete, due parole che dovrebbero essere le più prestigiose e vitali della Storia attuale. Siamo sempre in rete, ma non per fare rete: nell’online cerchiamo di fare brand marketing, di promuovere la nostra immagine, di salvare noi stessi invece che veicolare un messaggio collettivo: con «le armi da tastiera» fendiamo colpi mortali e autoritari su alcuni argomenti, anche se non ne siamo gran conoscitori, divenendo portatori sani di falsi moralismi (e informazioni). Dietro «lo scudo dello schermo» siamo sapienti, coraggiosi, pronti ad accettare sfide impossibili e a rivoluzionare il mondo con iconico eroismo, pronti a divenire i poli centrali dell’internet, gli eletti. Rilasciamo pillole di conoscenza e magnanimità che, magari, neanche sono nostre, ma sono incollate da Wikipedia, che è un agglomerato di contributi di vari utenti, che scriviamo noi. Un cane che si morde la coda.
Siamo fautori di una conoscenza acquisita leggendo titoli online di siti dai nomi improponibili e da visual clickbaiting di content creator che, al massimo, hanno il pregio di creare un hook forte e vigoroso. Grazie a queste iconoclastiche informazioni (Senza fonte, Senza fact-checking, Senza contraddittorio), «lanciamo [iconoclastiche] opinioni fino a sera», con il solo intento di far sentire la nostra presenza. Preferiamo urlare alle fake news, soprattutto a quelle più banali, Senza accorgerci che caschiamo ogni giorno in esse. Capita a tutti.
In tutto questo, ci scandalizziamo, il web si indigna, «inizia la bufera, codardo chi non c’era». Ma su cosa? Sulla fuffa. Sul nuovo programma televisivo, sui tradizionali nasoni romani, sui divieti orari imposti sull’alcool, sul cantante – o presunto tale – che si esibisce in playback. Risse sociali a non finire, e contemporaneamente i numeri della povertà crescono, altalene accessibili vengono chiuse e leggi moderne restano fuori la porta di Montecitorio. Silenzio, però, mica dobbiamo parlarne. O, meglio, mica dobbiamo usare questi strumenti di ultima generazione che potrebbero aiutare le nostre questioni sociali. Perché, sì sa, porta sfortuna. O diventi perbenista, alla peggio. La questione è semplice: preferisco farti vedere la mia vacanza a Ibiza pagata coi soldi di qualche mio parente, invece che darti un’emozione, anche di rivolta. Cliché? Può darsi, come il silenzio comune quotidiano, perché la lotta ormai passa attraverso il modem. E se non ce l’hai, sei fuori dal mondo. Non esisti. E non sei quantificabile, degno di nota.
Indignazione che, comunque, dura veramente poco. Il tempo di un trend, perché poi accade altro e bisogna indignarsi di quello. E il tema precedente? Svanito, come se non esistesse. Oh, io tanto la stories su Instagram l’ho condivisa, il mio senso di responsabilità sociale è stato appagato. Ora scusate, è diventato virale un altro argomento, è più importante.
Sì, i social network la fanno da padrona sulle nostre vite e su ciò di cui vogliamo parlare. Sembra che non ce ne rendiamo conto. Abbiamo ridato un lavoro a un fautore del trash, ma ci lamentiamo che non ci sia per noi, o che non abbiamo il lavoro del fautore del trash. Certo, ognuna utilizza il proprio strumento come meglio crede: ma da quando esiste la realtà virtuale, ogni più piccola parola, foto o video comincia ad avere un peso enorme. Ma noi ce ne freghiamo.
E pensare che oggi il mondo della comunicazione è svalutato dalle stesse società che, consapevoli di quanto sia fondamentale la comunicazione, la retribuiscono poco: perché così è più facile distorcere e controllare la sua libertà.
Ma a noi cosa interessa? L’individuo accetta la situazione, perché si deve salvare, e lascia marcire quelli che non assecondano una realtà disgustosa. “Di che mi lamento? C’è chi sta peggio”, si dice ogni giorno. Una frase che accetta l’idea che qualcuno possa non avere una casa e morire per strada, tanto non sono io a dormire al freddo stanotte.
Suggeriscono di accettare la vita così com’è, tanto c’è qualcuno che sta peggio, ma allo stesso tempo si piangono addosso a causa della propria società. Una società formata da noi stessi, dalle nostre azioni e dal modo in cui vivono il mondo. Anche se non vogliamo sentirci responsabili, lo siamo. Ne facciamo parte, anche semplicemente quando compriamo oggetti da siti che sfruttano il lavoro minorile: ci fa schifo, ma ne incentiviamo l’esistenza continuando ad acquistare a pochissimi euro. Tanto mica sono bambini che conosco, che vedo, che sento. Insomma, non ce ne frega niente.
La comunicazione è l’arma attuale più potente che abbiamo. Il passato lo insegna, ma il presente se lo sta lentamente dimenticando. E l’arte ne risente, mentre il fucile resta più carico che mai. Perché la pace non la si porta comunicando, ma sparando. Che sia un bang, che sia “a zero”.
Il problema è che non ce ne frega niente. O meglio, sono in molti a fregarsene. Ognuno difende il proprio orticello dagli sguardi altrui, vuole creare invidia che riversa sui propri contenuti online. Perché l’obiettivo è questo: creare invidia e divario sociale. Ho ciò che tu non potrai mai avere, anche se non l’ho conquistato da solo, e godo. Ostento la mia fortuna sulla tua sfortuna, il mio idolo ballerino – sullo yacht coi soldi che non sono suoi – approverebbe. Non abbiamo tempo per informarci, non abbiamo tempo per scegliere una fetta della nostra società da difendere, non abbiamo tempo per scrivere contenuti ritenuti importanti per il nostro futuro. Ma lo abbiamo per idolatrare e condividere artefatti umani, quello sì. Perché è facile, perché è semplice, perché è deresponsabilizzante. Guai a dire che esiste una responsabilità collettiva.
E in tutto questo restiamo a guardare, a fissare lo schermo. Non faccio parte del gruppo, dunque perché mi preoccupo? Sì, è così. Perché tanto, «la gente grida aiuto», ma «io spero non capiti a me».